L’uso di accompagnare i testi con immagini dipinte è già testimoniato in età classica, cui pervenne forse dall’antico Egitto, dove i Libri dei morti, databili al XVII secolo a.C., presentavano ideogrammi accanto ai segni grafici di tipo fonetico. Sappiamo che in ambito romano, in cui comunque la decorazione dei testi dovette avere carattere sporadico, alcune opere erano precedute dall’effigie dell’autore.

La più antica testimonianza di un libro miniato è in Marziale, che cita un
Virgilio illustrato del I secolo d.C., oggi perduto.
Tuttavia nessun testimone d’epoca antica è giunto fino a noi, cosicché per giudicare delle forme di quell’arte occorre risalire ai libri miniati del IV e V secolo, epoca in cui si afferma il passaggio dal ‘rotulus’ o ‘volumen’ al
‘codex’: il celebre Virgilio Vaticano (Lat. 3225) riflette nel suo stile compendiario di matrice ellenistica modelli più antichi.
Varietà nella decorazione e nella funzione del libro miniato riflettono vicende e usi diversi di cui il volume è protagonista: il codice miniato è strumento di
predicazione ed esaltazione della parola di Dio nelle mani dei missionari, strumento di potere e ostentazione politica per sovrani e imperatori, oggetto di devozione privata o di istruzione, manifestazione di lusso e mecenatismo.
Il tipo di illustrazione segue l’evolversi della cultura e dei gusti letterari: in ambito umanistico, alla riscoperta della cultura classica e al rinnovo dei caratteri della scrittura si accompagna la rielaborazione di motivi decorativi a tralci vegetali stilizzati, di ascendenza carolingia, noti come bianchi girari o
girari a bianchi.
Diversi sono gli elementi che definiscono la fisionomia del libro miniato; il primo è la tinta della pergamena, il più delle volte usata nella sua colorazione naturale, ma che appare dipinta di porpora già in codici di contenuto religioso del I secolo realizzati in Oriente, dove il rosso è messo in relazione simbolica con la persona divina. Per la sua connessione con il concetto di divinità, in Occidente codici purpurei furono realizzati nell’ambito della corte imperiale di Carlo Magno, mentre nel XV secolo su pergamena purpurea furono vergati esemplari d’omaggio di raccolte liriche.
Più rari sono i manoscritti con pergamena tinta di nero.
La scrittura stessa può concorrere all’ornato di un volume, per esempio nel caso in cui i caratteri siano realizzati in oro o argento, utilizzati il più delle volte in connessione con la pergamena purpurea. La lettera, e in particolar modo l’iniziale, è storicamente l’oggetto principale della decorazione: tale fenomeno trae origine dalla consuetudine di evidenziare con inchiostri differenziati le iniziali dei paragrafi e delle partizioni secondarie di un testo per renderne più intellegibile la struttura.
Le iniziali rubricate sono generalmente realizzate dallo stesso scriba. Una
versione più elaborata è la cosiddetta iniziale calligrafica, in cui il corpo della lettera, chiaramente leggibile e di dimensioni generalmente modeste, è rivestito di un fitto intreccio di grafismi filiformi eseguiti con inchiostri colorati che si ramificano lungo i margini della pagina.
L’iniziale ornata o decorata, che si afferma nel corso del VI secolo, consiste invece in una lettera la cui struttura è interamente risolta in senso decorativo tramite un disegno che, nel rispetto del segno grafico astratto, la arricchisce di elementi geometrici, fitomorfi o zoomorfi stilizzati che possono giungere a invadere l’intera pagina (decorazione a tappeto). Nella lettera figurata, diffusa soprattutto in ambito medievale, un intreccio fantastico di figure zoomorfe o mostruose è disposto a rendere il disegno dell’iniziale.
La lettera istoriata, eventualmente racchiusa entro uno sfondo di formato quadrangolare, contiene all’interno del campo una scena con figure, di norma in relazione con il testo illustrato. Infine possono aversi vignette isolate nella pagina e separate dal testo mediante cornice, o ancora miniature a piena pagina, cui eventualmente può sovrapporsi qualche parola dell’incipit del testo. All’ornato che coinvolge il campo della scrittura si unisce la decorazione marginale, di norma costituita da tralci vegetali, fioriti e talvolta abitati da animali e, soprattutto negli esemplari del XV secolo, putti.
E nell’ambito delle decorazioni marginali che trovano posto immagini prive di relazione con il testo, di gusto vivace e sbrigliato, animali mostruosi e
fantastici, i cosiddetti grilli, o ancora scene di gusto popolare e aneddotico di ispirazione grottesca, ‘droleries’.
Nella seconda metà del XV secolo l’impostazione bidimensionale della decorazione
miniata entra in crisi e si afferma il gusto per immagini in trompe l’oeil: il miniatore finge che il testo sia scritto su una pergamena, spesso lacerata
ad accentuare l’effetto illusionistico, appesa a una struttura architettonica classicheggiante. L’organizzazione della bottega e le tappe di produzione del codice miniato non sono esemplificabili in uno schema costante, rispondendo a
tradizioni locali e alle esigenze di una clientela differenziata.
Di regola tuttavia la decorazione segue nel tempo l’intervento dello scriba, e precede la rilegatura in volume dei fascicoli. Nel caso di ornati in oro, il metallo veniva steso a pennello o più spesso in foglia prima dei pigmenti, e poi brunito.
La decorazione del codice, affidata al capo bottega, è di norma divisa tra i suoi aiuti: l’unità base del lavoro è allora costituita dal fascicolo
di fogli. La divisione dei compiti segue criteri variabili, legati all’importanza delle immagini: il maestro può riservarsi l’esecuzione del frontespizio e delle scene principali, realizzando sugli altri fogli disegni più o meno dettagliati che gli aiuti di bottega ultimeranno.
In generale sembra di poter evidenziare una specializzazione di compiti
tra miniatori impiegati nelle parti decorative (lettere, motivi ornamentali) e artisti attivi nelle scene figurate. Tale divisione dei ruoli è talvolta riflessa sul piano lessicale dai documenti nella distinzione tra ‘illuminator’, ‘miniator’ e ‘historiator’.
Tuttavia anche in questo caso non bisognerà pretendere dalle fonti antiche un uso rigoroso dei termini tecnici. In Francia è per esempio documentata anche l’espressione ‘enlumineur d’histoires’.
L’esecuzione delle miniature dopo la trascrizione del testo comporta la necessità che, nel momento della definizione del formato e delle componenti materiali del volume, il piano generale dell’illustrazione sia già stato definito.
Lo scriba dovrà infatti tener conto dello spazio da lasciare in bianco per l’esecuzione di lettere e scene miniate. Ciò pone naturalmente il problema dell’intervento di un personaggio in grado di definire il piano illustrativo del volume prima della sua composizione. Tale ruolo sarà stato assunto il più del-
le volte dallo stesso capo bottega, ma non è da escludersi che nei casi di illustrazioni complesse, soprattutto in presenza di testi privi di una tradizione figurativa o il cui apparato decorativo rivestisse un particolare interesse per il committente, un altro personaggio intervenisse al fianco del miniatore.
In qualche esemplare sono ancora presenti a lato delle miniature finite le indicazioni manoscritte relative al soggetto da illustrarsi, che in generale dovevano essere grattate a lavoro ultimato, prima della rilegatura.
Nel caso di illustrazioni di particolare impegno e onere economico, il miniatore poteva inoltre essere tenuto a presentare una prova del proprio talento. In molti casi doveva funzionare all’interno delle botteghe, e forse anche tra una bottega e l’altra, un sistema di circolazione di repertori decorativi e figurativi destinati a fornire modelli precisi o schemi di distribuzione delle immagini, almeno per ciò che concerne i volumi di più ampia diffusione, come
i libri d’Ore e le Bibbie moralizzate (Libro di modelli di Guiniforte da Vimercate, Bloomington, The Lilly Library, Ms. Ricketts 240).
La miniatura trovò un altro campo di applicazione, seppure in quantità più modesta, con l’avvento della stampa. Soprattutto in ambito veneto alcuni incunaboli, per l’occasione impressi su pergamena, furono riccamente decorati su richiesta degli acquirenti.
Fonti:
Adversi “La storia del libro” Firenze 1963
J.P. Feather e D. McKitterick “The history of books” Washington 1986
“Manuale Ecniclopedico della Bibliofilia”, Edizioni Sylvestre Bonnard 1997
Hai domande o richieste particolari? Contattaci e saremo lieti di assisterti nella tua esplorazione del mondo dei libri antichi.
Generalmente rispondiamo in 24/48 ore a causa delle numerose richieste
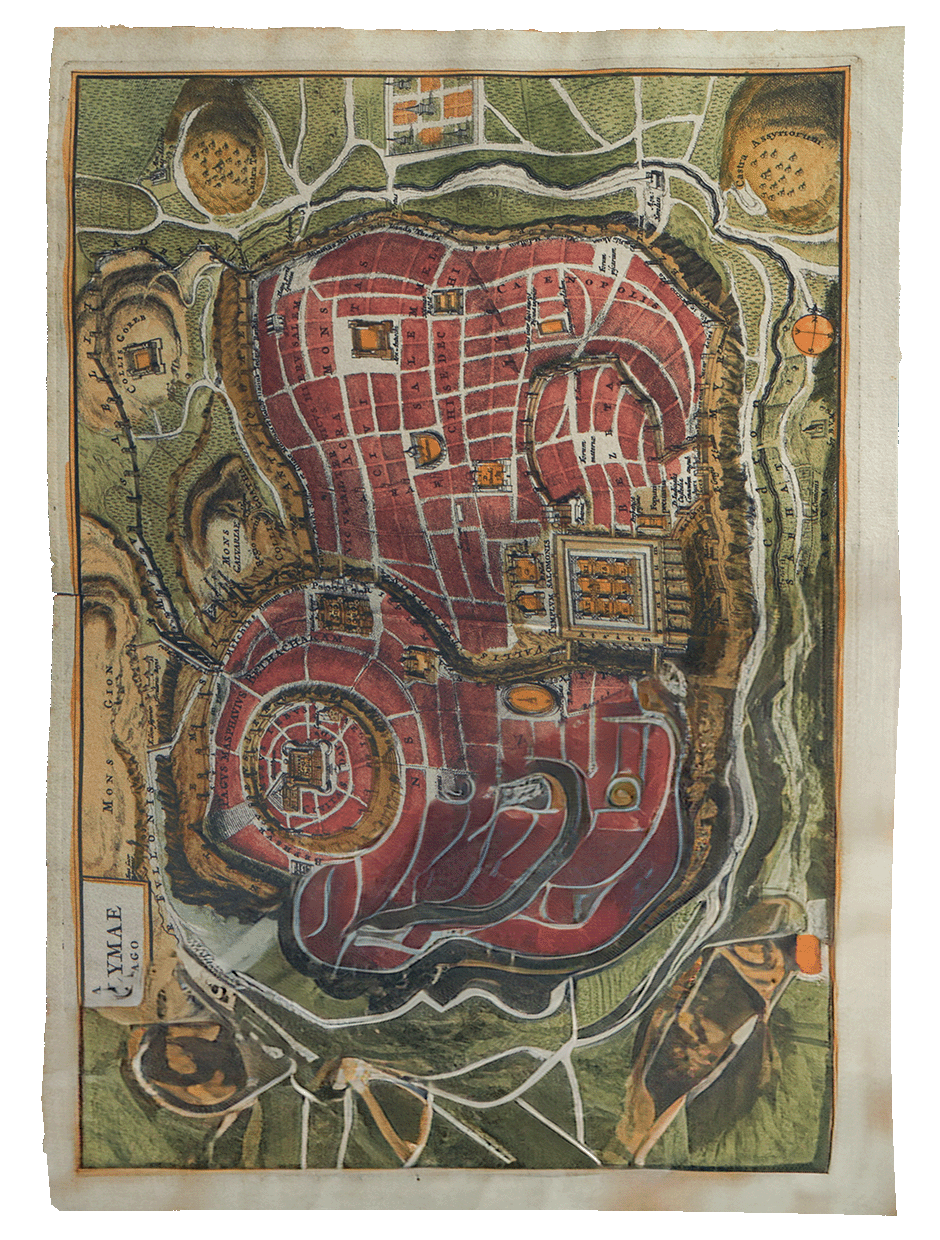
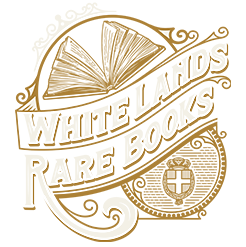
Dove siamo
White Lands Rare Books
Via Andrea Doria, 19
10123 Torino TO
Orari di apertura
Lunedì: Chiuso
Martedì a Sabato: al mattino solo su appuntamento – apertura al pubblico 15:30–19:30
Domenica: Chiuso
Contatti
Tel: 011 19036518
Whatsapp: 377 3765217
Email: info@whitelands.it
P.IVA: 12148150019
Made with 💓 by Zeta3